«Quel che è stato sarà»: per la nostra rubrica di critica pavesiana contemporanea, Iuri Moscardi ha intervistato Giancarlo Pontiggia, autore di un recente commento ai Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese.

Nell’introduzione a «Quel che è stato sarà», lei scrive che venne folgorato da ragazzo dai Dialoghi e da Feria d’agosto, libri pavesiani meno ‘di moda’. Cosa fu a catturare la sua attenzione in giovane età quando – come precisa ancora nell’introduzione – la portata del libro non era ancora completamente chiara?
Alla fine degli anni Sessanta Pavese era un autore molto letto, per lo più entro un’ottica civile, se non politica. Ricordo il mio esame di maturità nel luglio del 1971. Avevo preparato un piccolo lavoro sulla sua opera, centrato sui Dialoghi con Leucò, ma i professori della commissione continuavano a spostare il discorso su romanzi come Il carcere, Il compagno, La casa in collina, e naturalmente La luna e i falò. Io avevo letto – tra l’altro – i saggi pavesiani di Furio Jesi, contenuti nel volume Letteratura e mito, e la cosa parve assai strana, perfino sospetta. Ma all’epoca Pavese era un’icona della letteratura impegnata, e i Dialoghi venivano interpretati come una sorta di imbarazzante incidente di percorso. In realtà – come oggi ben sappiamo – gli interessi mitici di Pavese venivano da lontano, e pervadevano gran parte del mondo poetico e narrativo dell’autore: ma si continuava a interpretare il mondo pavesiano all’interno di quelle categorie naturaliste e veriste – qualcuno diceva perfino neorealiste – che negli ultimi anni della sua vita lo stesso Pavese aveva inutilmente cercato di allontanare da sé. Eppure, sarebbe bastato leggere con attenzione certe pagine del Mestiere, o l’ultima sezione di Feria d’agosto, o le bellissime pagine del Diavolo sulle colline per cogliere il dato profondo della ricerca pavesiana, che proprio Jesi aveva indicato con tanta precisione nei suoi saggi. Quando leggevo Pavese, e non solo il libro dei Dialoghi, io sentivo qualcosa che esulava dalla materia narrata, e che mi riportava al mondo dei tragici, dei Misteri, delle filosofie orfiche, del tardo Platone. Qualcosa che non avrei mai potuto trovare in nessun altro scrittore italiano del Novecento. Ma Pavese è sempre rimasto – nonostante abbia scritto e operato nel cuore della nuova editoria italiana – uno scrittore appartato cui guardare con qualche perplessità: e forse proprio in questa sua resistenza segreta alle parole d’ordine delle riviste militanti, delle ideologie politiche, dei dibattiti sul destino della letteratura, in questa sua caparbia volontà di addentrarsi nelle ragioni profonde – spesso contraddittorie – del fare poetico, era gran parte del fascino che esercitava su di noi, ragazzi nati quando l’autore dei misteriosi Dialoghi con Leucò si era già congedato dal mondo. Una morte – per il modo con cui si era consumata – che a noi parve subito carica di segni sacrificali e profetici, come se alludesse a un futuro in cui la letteratura sarebbe stata sempre più oggetto di falsificazioni e di equivoci.
Nell’introduzione scrive anche che nei Dialoghi lei e gli altri giovani, folgorati da questo libro, sentivate “che in gioco era la vita, ed era il senso della poesia stessa”. Essendo lei poeta, quanto hanno influito i Dialoghi sulla sua poesia? Quanto ha influito il suo essere poeta in questo commento dei Dialoghi?
La sensazione che i Dialoghi fossero soprattutto un libro di poesia viene da lontano, e appartiene agli anni in cui mi capitò di scoprire l’intera opera pavesiana. Avevo già letto, all’epoca, le Illuminations di Rimbaud e Le Spleen de Paris di Baudelaire: sapevo insomma che si poteva fare poesia anche oltre il verso. Ma la tensione poetica dei Dialoghi andava ben oltre la questione della prosa, dei suoi accentuati valori ritmici, o della fitta trama di ripetizioni e di riprese che Pavese poteva avere appreso dalla lettura dei poemi omerici. Mi pareva riguardasse invece la sostanza stessa dell’ispirazione e della visione. Il fatto è che solo la poesia – intesa non come forma ma come pensiero del mondo – è in grado di sviluppare una tensione come quella che leggiamo nei Dialoghi o in alcune prose di Feria d’agosto. Il campo di granturco [da cui è tratto il tema del Pavese Festival 2023, ndr] è un racconto che vive tutto in quel fruscìo di steli secchi che si muovono nell’aria, e nei «colloqui remoti» che quel fruscìo sa suscitare nel cuore dell’io narrante. Immagini, sensazioni, epifanie del cuore. E lo stesso accade in pagine come La vigna, o nel bellissimo incipit di Storia segreta, con quella strada che «saliva alle nuvole». E dentro, ogni volta, è un ragazzo, uno che continua a starsene tutto solo nella vigna o sotto un portico, nascosto negli anfratti di una memoria più arcaica, come il puer aeternus di junghiana memoria. Quelle intuizioni sono sempre state in me come qualcosa di decisivo, che un lettore sensibile potrebbe certo rinvenire in qualche poesia di Con parole remote o di Bosco del tempo. Remoto, d’altronde, è un lemma pavesiano che ricorre in molte pagine di Feria d’agosto: e in quel remoto è molta della grande poesia novecentesca in cui mi sono riconosciuto.
È celebre la definizione che Pavese diede del sé poeta: una delle voci più isolate della sua generazione. Come vede oggi gli studi sul Pavese poeta? Che peso hanno nel definire l’immagine odierna di Pavese, che fu anche romanziere, traduttore e funzionario editoriale?
Non sono uno studioso di Pavese, e anche se ho letto buona parte degli studi critici che gli sono stati dedicati, non posseggo una visione complessiva della bibliografia pavesiana. Vedo però che continuano a gravare sul nome di Pavese gli stessi equivoci di un tempo. Le recenti edizioni, per Aragno, del Taccuino segreto e della traduzione pavesiana della Volontà di potenza insistono su temi di carattere politico, rinnovando le accuse di decadentismo e di irrazionalismo che già furono di Moravia più di mezzo secolo fa. Chi parla entro questa prospettiva commette un errore che poteva essere forse parzialmente scusato, a voler essere generosi, all’epoca della guerra fredda e della divisione del mondo in due blocchi contrapposti. La grande letteratura non è nata per dar conto di appartenenze ideologiche o politiche: segue una logica di tempi lunghi; è sempre percorsa, negli esiti più alti, da un afflato mitico; deve far sentire la vastità dei moti cosmici, il peso dei cieli che fanno inclinare il mondo, e dunque anche l’animo dell’uomo. Pensi se applicassimo dei parametri sociologici o politici alla lettura dei grandi classici: qualcuno potrebbe osservare, per esempio, che l’Eneide di Virgilio, così come i carmina oraziani, sono opere eccessivamente sbilanciate a favore della politica augustea. Ho studiato alla Statale di Milano negli anni Settanta, dove poteva capitare di assistere alle contestazioni che il Movimento Studentesco rivolgeva contro un professore accusato di leggere la Commedia di Dante: un altro grande reazionario, come sappiamo… Per fortuna, a proposito della poesia di Pavese, è uscito il volume mondadoriano curato da Antonio Sichera e da Antonio Di Silvestro [che abbiamo intervistato per questa rubrica, ndr]. Un lavoro che restituisce il senso del lungo viaggio di Pavese – spesso contraddittorio e magmatico – dentro il corpo della poesia: e nel quale un ruolo fondamentale hanno rivestito le traduzioni (dalle lingue moderne come da quelle classiche), nonché l’immane lavoro editoriale condotto – sempre con libertà, acume, anche ironia – dall’autore. E vedo che anche le poesie di Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, che molti, in passato, avevano giudicato un “arretramento” rispetto alla produzione precedente, vengono lette sempre più sul piano della continuità: e lo conferma non solo il lavoro di Sichera-Di Silvestro, ma anche una recente postfazione di Giovanni Tesio al volume Donne appassionate. Poesie d’amore e morte (2022), nella quale, tra l’altro, si sottolineano anche le affinità tra il concetto di «poesia immagine» e alcuni coevi procedimenti ermetici.
Lei considera i Dialoghi opera di poesia, non prosa, aggiungendo di aver voluto “restituire la necessaria dimensione fantastica del suo farsi”. È per questi motivi che ha voluto presentare i Dialoghi ai lettori come un commento, ovvero un genere solitamente riservato alla poesia?
È vero, di solito la forma-commento viene riservata ai testi poetici, che presentano una stratificazione di senso maggiore di un testo in prosa. È un’altra prova, a ben guardare, della sostanza poetica di questo libro. Aver poi scelto di seguire, nel commento, non l’indice conclusivo approntato dall’autore, ma la cronologia di stesura dei singoli dialoghi, mi ha consentito di accedere ai nessi profondi – immaginativi ed espressivi – che sempre operano nel farsi di un lavoro, e che non necessariamente rispondono a un progetto intenzionale e controllato. Sono moti ondivaghi, fantastici, in cui chi scrive è come misteriosamente guidato da quello che sta scrivendo, dal fermento empirico, spesso arbitrario e non calcolabile, della sua ispirazione.
I titoli non sono mai neutri. Come mai ha scelto «Quel che è stato sarà», un passo ricorrente nei Dialoghi e nel Mestiere di vivere che indica l’impossibilità di opporsi al destino?
La frase ha una sua forza scultorea, e un suo indiscutibile peso oggettivo: come nel pensiero dei grandi tragici greci, che sono ben presenti nell’immaginario dei Dialoghi, e come in Leopardi, un’altra presenza fondante della poetica pavesiana, la scrittura dei Dialoghi nasce dalla volontà di indagare le leggi profonde del reale, e dalla ferma risoluzione di non attenuare la sostanza tragica delle scoperte. Penso all’Inconsolabile, dove la frase del mio titolo (nella variante «Ciò ch’è stato sarà») ricorre fin dalle prime battute del protagonista. Cercando se stesso, Orfeo scopre il proprio destino. Da quel momento, non può più tornare indietro, non può più credere «che quello che è stato si possa disfare», né può più illudersi di «rompere il destino con l’ebbrezza», che è con tutta evidenza un preciso riferimento al mondo dei Misteri. Non si viola un destino, come non si può vincere la notte. Non si tratta dunque di essere pessimisti o ottimisti, ma di entrare nel vero delle cose, nel tragico della condizione umana. Come ha scritto Sergio Givone, «Se tutto ciò che è, sarà, allora una condanna metafisica grava sull’essere in quanto tale. La vita sta nel segno della morte, che dunque l’anticipa e la marchia irrimediabilmente». I Dialoghi si inseriscono con forza nella grande linea di un pensiero che va dai tragici a Leopardi, e da Leopardi a Pirandello e a Montale: e stiamo parlando dei grandi della nostra modernità letteraria.
“Un Pavese ci vuole”: ho usato questa semi-citazione da un famoso passaggio de La luna e i falò per una serie di video-interviste con il direttore della Fondazione Cesare Pavese, Pierluigi Vaccaneo. Settantatré anni dopo il suicidio di Pavese, abbiamo ancora bisogno di lui? Perché?
Abbiamo sempre più bisogno della voce dei grandi scrittori, e ancor più di quegli scrittori che si sono spesi fino in fondo per cogliere una parola decisiva, che valesse per chi scrive ma soprattutto per chi legge. La tensione conoscitiva che anima ogni lavoro di Cesare Pavese, il coraggio di non eludere le zone più scure dell’animo umano, e nondimeno la consapevolezza che nessuno scrittore – se è veramente tale – possa rinunciare alla potenza illuminatrice del pensiero sono il sigillo della sua ricerca espressiva. E tanto più la sua voce ci appare necessaria oggi, in un’epoca, come quella che stiamo traversando, a lungo logorata da una visione ideologica, greve, mortificante dei fatti sociali e culturali, così come – paradossalmente – da una sorta di sottile nichilismo, che sembra volto a sottrarre significato a tutto ciò che facciamo, pensiamo o leggiamo, come se ogni gesto fosse uguale a un altro, come se su ogni oggetto del nostro sapere si stendesse la grande ala del dubbio corrosivo, il cui esito finale è solo il silenzio della parola, la sospensione di ogni giudizio. Nelle pagine di Pavese, al contrario, sentiamo che agisce sempre una forma – non importa quanto controversa – della verità, qualcosa che ci tocca anche nell’errore, anche quando sentiamo di precipitare nelle zone più sorde e inquietanti della psiche umana. Pavese credeva nel potere indagatore e chiarificatore della parola, e dunque nella natura civile della ricerca letteraria, che è una sintesi di lingua, immaginazione e pensiero. Quasi un antidoto a ciò che sta accadendo oggi, un po’ in ogni parte del mondo, e che potremmo riassumere così: un pensiero sempre più sopraffatto dall’onda fascinosa e incantatoria delle piccole emozioni; una lingua annacquata e semplificata, come se gli scrittori si formassero, ormai, da troppi anni, su una lingua inesistente, che è quella delle traduzioni, e avessero smarrito la dantesca «gloria de la lingua»; una tensione immaginativa sempre più arresa al libero flusso delle ossessioni egotiche e soggettive. Ma Pavese continuerà a parlare alle nostre coscienze, almeno finché ci saranno lettori alla sua altezza.

Dialoghi con Pavese: Tommaso Munari
Per la nostra rubrica di critica pavesiana contemporanea, Iuri Moscardi ha intervistato Tommaso Munari, autore del saggio “L’Italia dei libri. L’editoria in dieci storie”.

Dialoghi con Pavese: Sara Vergari
Per la nostra rubrica di critica pavesiana contemporanea, Iuri Moscardi ha intervistato la ricercatrice Sara Vergari, autrice del saggio Un “Pavese solo”.
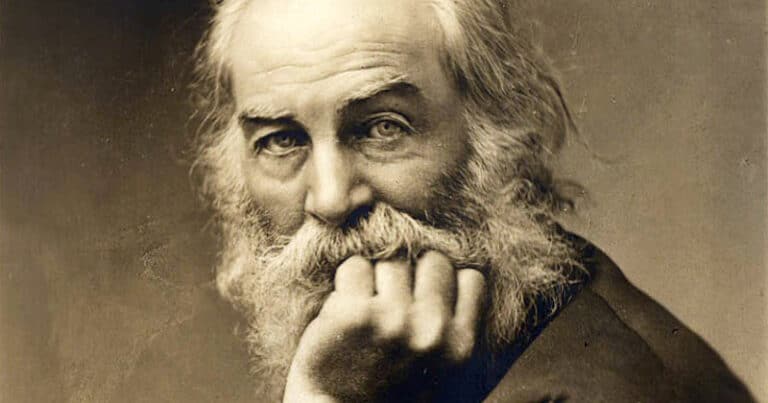
Dialoghi con Pavese: Lawrence Smith
Per la nostra rubrica di critica pavesiana contemporanea, Iuri Moscardi è tornato a intervistare Lawrence Smith a proposito della sua recente traduzione inglese della tesi di laurea di Cesare Pavese.



