Un unicum ancora molto attuale: per Dialoghi con Pavese abbiamo intervistato il professor Alberto Bertoni che ha recentemente curato la riedizione di Lavorare stanca.
Alberto Bertoni è dal 2016 professore ordinario nel Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, dove insegna Letteratura italiana contemporanea (Laurea triennale) e Prosa e generi narrativi del Novecento e Poesia italiana del Novecento (Laurea magistrale). Esperto di metrica, poesia e narrativa contemporanee, è autore di numerosi studi, articoli e libri. Tra questi: i Taccuini 1915-1921 di Filippo Tommaso Marinetti a partire dagli autografi conservati a Yale (1987); il capitolo L’Emilia e la Romagna nella Letteratura italiana Einaudi diretta da Alberto Asor Rosa (1989); Dai simbolisti al Novecento. Le origini del verso libero italiano (1995, premio Luigi Russo e Benedetto Croce per la saggistica); Una distratta venerazione. La poesia metrica di Giudici (2001); l’antologia Trent’anni di Novecento. Libri italiani di poesia e dintorni (1971-2000) (2005); la cura delle Poesie (2007) e dei Romanzi di Alberto Bevilacqua (2010); la cura del Quaderno di quattro anni di Eugenio Montale (2015); Poesia italiana dal Novecento a oggi (2019) e Una questione finale. Poesia e pensiero da Auschwitz (2020). È anche autore dell’autobiografia a quattro mani con Francesco Guccini Non so che viso avesse (2010). Nel 2021, per l’editore Interno Poesia ha curato un’edizione di Lavorare stanca, la prima raccolta poetica di Cesare Pavese (1936 e 1943), pubblicata con una nota al testo di Elena Grazioli.
Ph. @Dino Ignani
Ha appena curato una nuova edizione di Lavorare stanca, la raccolta di poesie per cui Pavese scelse come fascetta: «Una delle voci più isolate della poesia contemporanea». Da cosa gli derivava questa consapevolezza e cosa significava all’epoca essere poeticamente isolati?
Significava essere estranei agli schemi prefissati di un regime e di una cultura accademica che cominciavano ad andare di pari passo. Da un lato, i modelli accettati e tramandati di poesia “moderna” annettevano una semplificazione piuttosto meccanica – e radicata nell’insegnamento scolastico – delle poetiche simboliste sperimentate da Pascoli (costretto in una dimensione fanciullina e campestre assai asfittica) e da d’Annunzio, proiettato in una prospettiva celebrativa e magniloquente che aveva poco che fare con le vibrazioni più nude e più segrete di una scrittura sempre più analitica e oggi si direbbe “decostruttiva”. Tutto questo, sullo sfondo di una classicità greco-romana posticcia e di cartapesta. Sull’altro versante, le sperimentazioni dei più giovani si incentravano sulla poetica dell’Ermetismo, sulla scia dell’Ungaretti del Sentimento del tempo (1933) e del primo Quasimodo. Gli adepti più giovani di tale poetica erano mossi da un cortocircuito di adesione cristiana (in particolare nel cospicuo gruppo fiorentino, capeggiato da Luzi e Bigongiari) e di Surrealismo depurato dei suoi sviluppi estremi e riadattato alla realtà italiana. Pavese è del tutto estraneo ad entrambe le prospettive e calibra scenari e temi del suo libro d’esordio, fondandoli invece su due nuclei originari di tutt’altra natura: quello antropologico del dissidio sempre più esplicito fra campagna e città (e fra vecchi e giovani, oltre che fra maschi e femmine), con la sua radice fiabesca e “dialettale”, in quanto tale invisa al regime; e quello del modello anglo-americano (soprattutto americano), che scaturiva da Whitman e da Melville nell’Ottocento, dall’epopea cinematografica del western e da quell’inclinazione a un realismo magico che era propria degli Sherwood Anderson o dei William Faulkner, già in pieno Novecento.
Nella sua introduzione scrive che solo di recente la critica ha iniziato a riconoscere in Lavorare stanca “un ruolo di unicum sia nella bibliografia pavesiana sia nello svolgimento novecentesco della poesia italiana ed europea”. Come mai prima il libro era poco considerato? Quali studi e ricerche hanno contribuito a questo cambio di prospettiva?
Andare contro una koinè generalizzata ha voluto dire per Lavorare stanca essere votato a una sorta di rimozione dal canone. Il libro infatti ha subito censura, fin dalla prima edizione del ’36, è coinciso col confino inflitto al suo autore per motivi speciosi, è uscito in seconda edizione proprio quando in Italia è cominciata la guerra civile, sancita dall’armistizio dell’8 settembre 1943, e il suo autore si è ritirato dalla scena pubblica, isolandosi in Monferrato. Nonostante la progressiva celebrità di Pavese, culminata nel suicidio dell’agosto 1950, Lavorare stanca è stato un libro in sostanza rimosso dal mainstream più accettato e celebrato (anche nel conflitto fra bellettrismo e sperimentazione) della nostra tradizione poetica quale è venuta svolgendosi nel secondo dopoguerra. Basti pensare alla totale incomprensione della profonda originalità e diversità del libro come è stata manifestata da due dei nostri più acuti interpreti di poesia contemporanea, Contini e Mengaldo, che l’hanno ridotto a una sorta di referto neorealistico. C’è voluto l’impegno pluriennale di lettori molto più empatici col Pavese poeta come Calvino e Mila, Guglielminetti e Coletti, Scarpa e Masoero per riconoscere a Lavorare stanca un ruolo innovativo e fecondatore, restituendolo alla sua dimensione non solo filologica e specialistica, ma profondamente umana e destinata davvero a un futuro ancora molto attuale, oggi che sono passati quasi settant’anni dalla sua ultima edizione.
Lei propone per il libro la definizione di sperimentalismo realistico e spiega l’influenza di Whitman e dell’America sul Pavese autore di queste poesie: possiamo spiegare in questo modo la compresenza di elementi realistici e mitici, che si intravedono sotto la superficie (e che in pochi hanno compreso)?
Senz’altro sì. Pavese con la sua laurea in letteratura angloamericana fu un innovatore fin dai suoi primi approcci letterari rispetto al contesto entro il quale sarebbe di lì a poco venuto ad operare: non soltanto come poeta alle prime armi (ventiduenne, verso il 1930), ma anche come traduttore precoce di Moby Dick (1932). Oggi ci sembra un bell’ossimoro e invece è un vincolo ermeneuticamente molto attivo, quello fra letteratura americana e mito. In questa chiave, è toccato a uno studioso dell’ultima generazione, ricercatore nel nostro Dipartimento bolognese di Italianistica, Riccardo Gasperina Geroni, di porre proficuamente l’accento su questo fondamento mitico di Lavorare stanca (che da un simile punto di vista può venire ricollegato tanto idealmente quanto cronologicamente alla straordinaria e pure originalissima intrapresa pavesiana dei Dialoghi con Leucò, usciti nel ’47), confermato anche dal rapporto necessario che Pavese intrattenne con l’etnologo e antropologo Ernesto De Martino.
A partire da quelli decisi da Pavese nella seconda edizione del 1943, la forma di questo libro ha subito molti cambiamenti. Come mai avete scelto l’ultima volontà dell’autore, stabilita nell’edizione del 1943?
È una scelta che rivendico. Pavese nel ’43 era già un personaggio eminente dentro il sistema ideativo e produttivo dell’Einaudi, fino a esserne riconosciuto negli anni immediatamente successivi quale vero e proprio direttore editoriale. Perciò, se avesse voluto modificare, integrare o correggere Lavorare stanca, avrebbe potuto farlo senza colpo ferire. Dunque, l’edizione 1943 corrisponde all’ultima volontà d’autore e – secondo la mia formazione filologica – tale volontà dev’essere assolutamente rispettata e assunta a punto di riferimento di ogni presente o futura riedizione del libro. Aggiungo anche, introducendo un punto di vista personale che può o deve venire tranquillamente contraddetto, che tale versione finale coincide con il capolavoro poetico di Pavese, autore anche più celebrato e ripetuto, grazie al successivo e testamentale Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, ma dal mio punto di vista assai meno perspicuo.
Il diario di Pavese reca traccia di molte riflessioni sulla forma di questa raccolta, che per lui doveva essere un canzoniere unitario e non un insieme di testi separati. Qual è la sua opinione?
La risposta più plausibile è che Pavese – per quanto concerne la macroforma della sua opera poetica – non è autore di un canzoniere, né avrebbe potuto esserlo. Il suo canzoniere coincide piuttosto con il sistema dei romanzi e dei racconti. Saba, che invece un canzoniere lo ha composto davvero, ne aveva già architettato una prima forma nel 1921, poi un’altra nel 1945: vale a dire che concepiva fin dall’inizio il suo opus poeticum come un canzoniere. E forse si può dire la stessa cosa per Sandro Penna e Amelia Rosselli: non certo per Ungaretti, per Montale o per Sereni, per citare tre esempi di qualità somma. Altra cosa sono gli opera omnia, le somme dei singoli libri di uno stesso autore o autrice. Ecco, qui sta il punto: il Novecento è il secolo del Libro di poesia, tutte le energie strutturanti sono volte alla composizione equilibrata, qualche volta romanzesca, in ogni caso compatta della singola raccolta. E dal punto di vista della coesione e della compattezza interne Lavorare stanca soddisfa senz’altro la ricerca pavesiana di compattezza e di unità. Ma non userei in proposito la parola canzoniere, che rimanda ad altro. Di autori come Giudici, Zanzotto, De Angelis, Magrelli esistono gli opera omnia, ma non si può dire che corrispondano a canzonieri. In loro, quasi ogni singolo libro ha una propria identità, di frequente una medesima lingua poetica, sempre uno specifico valore. Al di là delle sue speranze o dei propri pensieri di canzoniere, Pavese è autore di quell’unico libro di qualità assoluta e di valore differenziale rispetto al proprio contesto storico e stilistico: ed è Lavorare stanca, un libro profondamente innovativo anche sul piano della sperimentazione metrica, col suo verso lungo derivato da Whitman e non dall’endecasillabo italiano, oltre che su quelli di una varietà lessicale aperta agli anglismi e alle lingue del lavoro; e di un montaggio delle immagini di specie tutta cinematografica.
“Un Pavese ci vuole”: ho usato questa semi-citazione da un famoso passaggio de La luna e i falò come titolo di una serie di video-interviste con il direttore della Fondazione Cesare Pavese, Pierluigi Vaccaneo. Settantuno anni dopo il suicidio di Pavese, abbiamo ancora bisogno di lui? Perché?
Eccome se Pavese ci vuole ancora. Anzi mi spingerei fino ad affermare che, mentre nei primi anni Settanta, la funzione Pavese era stata incarnata con forza e capacità di penetrazione sempre più accentuate da cantautori (in primis, in Italia, da un Fabrizio De André) o da autori/registi/attori cinematografici, oggi si tende a tornare all’originale, anche all’interno delle generazioni più giovani. Ed è conseguenza della profonda onestà intellettuale di Pavese; del suo gusto sperimentale; della sua attenzione alla cultura americana (presto dominante in tutto il mondo occidentale); della sua stoffa inventiva non meno che ideativa e organizzativa; e infine del destino tragico scelto per la sua stessa vita, da quel giorno di agosto del 1950 definitivamente intrecciata alla sua opera letteraria e alla memoria che le generazioni successive si sono impegnate di volta in volta a ravvivare.
Intervista a cura di Iuri Moscardi
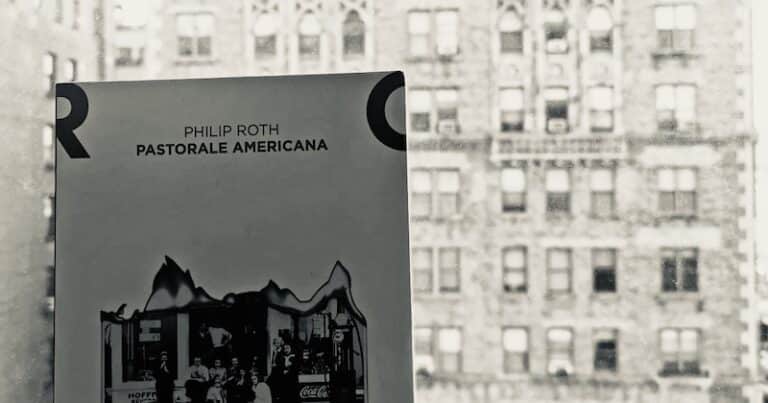
Dialoghi con Pavese: Francesco Samarini
Con l’autore di “Philip Roth e l’Italia”, Francesco Samarini, ripercorriamo il rapporto tra il gigante della letteratura americana e i grandi autori della nostra, Pavese incluso.

Dialoghi con Pavese: Antonio Sichera e Antonio Di Silvestro
Un “americano imbevuto di Bibbia e di Grecia”: così Antonio Sichera e Antonio Di Silvestro descrivono Cesare Pavese, di cui per Mondadori hanno curato la monumentale Opera poetica.
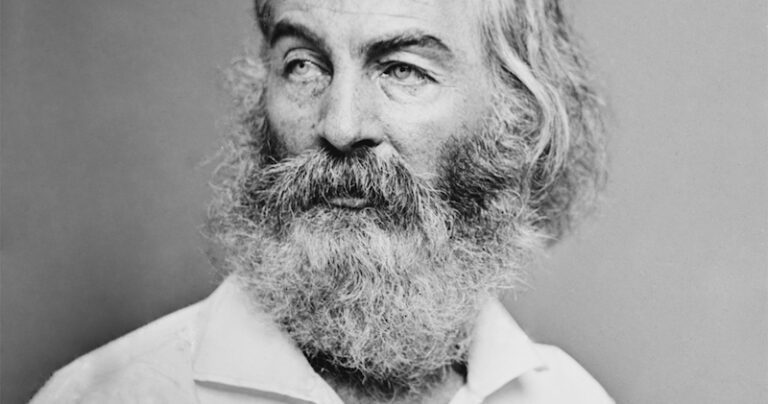
Dialoghi con Pavese: Caterina Bernardini
Oltre i confini nazionali, in cerca di interconnessioni e reciproche influenze: Caterina Bernardini racconta oltre dieci anni di ricerca su Walt Whitman, cui Pavese dedicò la sua tesi di laurea.



